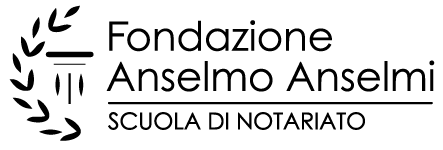Commissione Massime di Diritto Societario – Consiglio Notarile di Roma
Massime anno 2025
COMMISSIONE MASSIME DI DIRITTO SOCIETARIO DEL CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
MASSIMA 1/2025
La verbalizzazione a distanza e la sottoscrizione del presidente
(approvata il 2 ottobre 2025)
Fatta salva la normativa emergenziale di cui all’ art. 106, numero 2 secondo periodo del d. l. n. 18/2020 e successive proroghe, letti in maniera sistematica gli artt. 2375, 2371 e 2379 comma 3 c.c. e gli art. 51 e 60 della legge notarile, tenuto conto dell’ assenza di precedenti giurisprudenziali e del “caveat” apposto dal Consiglio Nazionale del Notariato[1] nella seduta del 21 luglio 2023 allo Studio n. 41/2023, si ritiene opportuno che il verbale di assemblea delle società di capitali redatto da notaio in funzione di segretario sia firmato anche dal presidente dell’assemblea oltre che dal notaio, al fine di evitare uno dei casi di potenziale impugnativa della delibera ex art. 2379, terzo comma, c.c.
Abstract
Partendo dall’analisi “sistematica” delle norme del Codice Civile e della Legge Notarile, ed alla luce della legislazione emergenziale introdotta dall’ art. 106 del d. l. n. 18/2020 che, per come prorogata, conferma il carattere altrimenti non derogabile delle prime, la presente Massima affronta il tema della “compresenza” e della funzione del presidente nella verbalizzazione delle deliberazioni assembleari di s.p.a. e s.r.l., a prescindere dalla redazione contestuale o differita del documento rispetto al momento della deliberazione, analizzando gli effetti che in assenza di normativa emergenziale potrebbe produrre la mancanza della sottoscrizione del presidente sulla verbalizzazione, sia sotto il profilo civilistico dell’invalidità potenziale che sotto il profilo probatorio alla luce della nozione di atto pubblico di cui all’art. 2700 c.c.
Si analizzano altresì le problematiche legate all’ambito di esplicazione dell’autonomia privata rispetto alla previsione statutaria dello svolgimento delle assemblee e riunioni dei soci con modalità “totalmente a distanza” e alla loro incidenza sulle regole civilistiche anche con specifico riferimento all’individuazione del luogo di convocazione, il tutto in linea con il richiamo prudenziale risultante espressamente dal “caveat” apposto dal Consiglio Nazionale del Notariato[2] nella seduta del 21 luglio 2023 allo Studio n. 41/2023, nonché delle recenti novità legislative in tema di svolgimento di assemblee di condominio in modalità telematica di cui all’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile che espressamente prevede la sottoscrizione del verbale da parte del presidente oltre che del segretario[3].
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, sembra opportuno ricordare che le disposizioni emergenziali previste dall’art. 106 del Decreto legge n. 18/2020 introdotto nel periodo “Covid” e oggetto di successive plurime proroghe (ultima quella al 31 dicembre 2025 prevista dalla legge 21 febbraio 2025 di conversione del D.L. 27 dicembre 2024, n. 22, in G.U., 24 febbraio 2025, n. 45) consentono, in via eccezionale, l’adozione di deliberazioni di assemblee di società di capitali e di enti con modalità telematiche “totalmente a distanza”. Norma, questa, che al comma 2 prevede che le riunioni possano svolgersi “[…] senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. […]”, con conseguente possibilità che il verbale sia sottoscritto da parte del solo notaio; nonché la possibilità - per le società con azioni quotate e per quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multimediale di negoziazione e per le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante – sia di designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente, sia di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58[4].
Si è posto il problema della disciplina applicabile a regime e nei periodi di mancata proroga[5].
Ai fini che qui rilevano, giova evidenziare, quale dato incontestabile, che in mancanza di una espressa previsione normativa e di orientamenti giurisprudenziali, le criticità sollevate dallo svolgimento a regime di assemblee con modalità totalmente a distanza, ossia svolte in videoconferenza senza la presenza fisica del presidente e del soggetto verbalizzante nel medesimo luogo sono molteplici ed operano su piani diversi: il piano del luogo della convocazione in rapporto alla competenza territoriale del notaio verbalizzante; il piano della potenziale invalidità del documento; il piano dell’efficacia probatoria; il piano dell’idoneità civilistica del documento a contenere dichiarazioni e momenti latamente negoziali.
In questo contesto, l’aspetto centrale della questione riguarda il tema della necessità o meno della sottoscrizione del verbale da parte del presidente oltre che del segretario/notaio. Aspetto, questo, che investe i più generali temi:
- del rapporto delle rispettive specifiche funzioni del presidente dell’assemblea (rectius: riunione) e del segretario verbalizzante per come delineate in generale dal codice civile[6];
- delle peculiarità della verbalizzazione ove segretario sia il notaio nell’esercizio delle sue funzioni, in applicazione della legge notarile;
- della natura giuridica del verbale di assemblea delle società di capitali redatto da notaio.
Problemi, tutti, la cui soluzione non può che essere rinvenuta nel complesso “sistema” normativo dettato dal legislatore in tema di verbalizzazione.
Pur essendo la presente Massima dedicata al rapporto delle rispettive specifiche funzioni nella verbalizzazione del presidente e del notaio che funga da segretario verbalizzante, non v’è chi non veda che, in generale, nel “sistema” della verbalizzazione delineato dal codice civile il rispettivo ruolo del presidente e del segretario abbia pari dignità sia nella fase dello svolgimento dei lavori che nella fase della creazione del documento, ferme le specificità delle rispettive funzioni.
Con riferimento alla verbalizzazione notarile, giova ricordare che le norme che attribuiscono al notaio la competenza della verbalizzazione delle deliberazioni assembleari di s.p.a. e delle decisioni dei soci che comportino modifica dello statuto per la S.r.l. non qualificano espressamente come atto pubblico il verbale. Ciononostante, si ritiene che nel sistema esistano elementi certi per qualificare il verbale come atto pubblico[7], con applicazione dell’art. 2699 c.c. e dell’art. 51, che fra gli elementi essenziali di forma degli atti notarili comprende la sottoscrizione delle parti (rectius: il presidente)[8]. Peraltro, anche per coloro che considerano il verbale un “atto pubblico sui generis” o senza parte, l’applicazione dell’art. 51 l. not. sarebbe ineludibile in considerazione del precetto dell’art. 60 della legge notarile che considera espressamente applicabili le disposizioni del CAPO I – Titolo III “ai testamenti e agli altri atti” senza possibilità di distinzione a seconda della riconducibilità dell’interesse al soggetto costituito che, in quanto tale, deve pertanto sottoscrivere ai sensi dell’art. 51 l. not.
Si discute infatti se il verbale di assemblea sia un atto pubblico in senso proprio ovvero un “atto pubblico senza parte” in considerazione del ruolo dei due “attori” della verbalizzazione: il presidente e il notaio, problema questo che, più in generale, investe il tema del rapporto delle funzioni del presidente e del segretario[9].
Sotto il profilo specifico della creazione del documento, i rispettivi ruoli del presidente e del segretario sono individuati nell’art. 2375, comma 1, c.c., nella parte in cui prevede che: “Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. [...]”. Se semanticamente le parole “… o dal notaio.” potrebbero indurre ad essere interpretate nel senso che la sottoscrizione del notaio possa essere sostitutiva delle sottoscrizioni sia del presidente che del segretario, in realtà una lettura non meramente semantica ma sistematica esclude una tale interpretazione in quanto, sempre semanticamente, già il tenore dell’art. 2379 terzo comma c.c. è molto chiaro nello stabilire che la sottoscrizione del notaio è sostitutiva del solo segretario e non anche del presidente, senza spazio per ulteriori e diverse interpretazioni[10]. Peraltro, è lo stesso legislatore che concepisce come alternativa la figura del segretario rispetto al notaio, come si desume testualmente dalla lettera dell’art. 2371 comma 2 che prevede: “L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è redatto da un notaio”, così chiarendo il significato della disgiuntiva “o” contenuta sia nell’art. 2375, comma 1, c.c. che nell’art. 2379, comma 3 c.c., nel senso che il notaio svolgerà la funzione di segretario e sarà lui il soggetto che dovrà sottoscrive il verbale insieme al presidente dell’assemblea[11].
L’art. 2379, comma 3 c.c.[12] prevede l’obbligo di sottoscrizione per entrambi i “coautori”[13] del documento ferme le specificità delle rispettive funzioni, a prescindere dalla natura ordinaria o straordinaria dell’assemblea, in guisa che il verbale non si considera mancante, tra l’altro, solo se sottoscritto dal presidente e dal segretario, ovvero dal presidente e dal notaio ove questi funga da segretario, essendo la verbalizzazione delle assemblee straordinarie di S.p.a. rimessa al notaio che funge da segretario così come la verbalizzazione delle decisioni dei soci di s.r.l. ai sensi dell’art. 2480 c.c.[14], per le quali per coerenza e per ragioni di “sistema” si ritiene di dovere applicare la prescrizione dell’art. 2375, comma 1 c.c. pur non essendo espressamente riprodotto in questo tipo sociale[15]. Questa conclusione, sia per la s.p.a. che per la s.r.l., prescinde dalla contestualità o meno della verbalizzazione poiché la previsione contenuta nello stesso art. 2375, ultimo comma, c.c. della c.d. verbalizzazione “differita” non reca dal punto di vista letterale alcuna deroga al principio sancito al comma primo dell’art. 2375 c.c.
Fatta salva la normativa emergenziale, si ritiene che il verbale, contestuale o differito, sia “atto pubblico con parte” (rectius: la società a mezzo del presidente in attuazione della sua funzione) che ha una speciale qualificazione e colorazione soggettiva in considerazione della provenienza e della riconducibilità dell’interesse all’organo collegiale che lo manifesta al notaio per il tramite del presidente, quale “rappresentante” (in senso lato) dell’ente, in attuazione delle prescrizioni del codice civile e della legge notarile. Il presidente dell’assemblea è “parte” del verbale perché è strumento necessario per realizzare l’interesse sociale alla attuazione del metodo collegiale[16] nel momento della formazione della volontà dell’organo collegiale poiché recepisce dall’assemblea “la sintesi” dei contrapposti interessi dei soci convergenti nel deliberato, esercitando la sua funzione con poteri autonomi per l’attuazione dell’interesse proprio alla corretta e veritiera verbalizzazione dei fatti e atti da lui constatati e dichiarati al notaio.
Del pari, il notaio svolge in maniera unitaria la sua funzione in tutte le fasi della verbalizzazione, sia essa contestuale che differita, senza poterne restringerne l’operatività al solo momento del “controllo” omologatorio che, ove previsto, è concepito come un’endiadi inscindibile del più generale controllo di legalità formale dell’atto notarile. La centralità della funzione attribuita al notaio dal legislatore nella verbalizzazione delle assemblee delle società di capitali e delle decisioni degli organi collegiali si manifesta e realizza nell’interpretazione delle volontà delle parti e della loro legittimità, nella dialettica, biunivoca ed imprescindibile, con la funzione del presidente dell’assemblea, per come sancita e delineata dall’art. 2371 c.c. e dall’art. 2375 c.c.[17].
Inoltre, in base alla opposta ricostruzione qui non condivisa[18], la peculiare natura del verbale quale “atto senza parte” giustificherebbe un’applicazione limitata dell’art. 51 l. not. con riferimento alla sottoscrizione del presidente, che sarebbe esclusa o rimessa alla scelta del notaio in base alla tecnica redazionale in concreto adottata e comportante o meno la costituzione in atto del presidente[19]. Tesi questa che non risulta condivisibile, oltre che per le ragioni sopra esposte, anche in virtù del disposto del sopra citato art. 60 della legge notarile che estende l’art. 51 a tutti gli “altri atti”.
Dall’art. 51 l. not. si desume che il principio della “compresenza” delle parti al momento della lettura del documento e della sua sottoscrizione non conosce deroghe se non nell’eccezionale ipotesi dell’atto di rettifica confezionato e sottoscritto dal solo notaio ai sensi dell’art. 59-bis l. not., principio peraltro confermato anche dalle proroghe dell’art. 106 d. l. n. 18/2020. In considerazione del carattere imperativo del principio, risulta opinabile la tesi di chi rimette alla scelta del notaio verbalizzante la costituzione in atto del presidente[20], nonché la legittimità di clausole statutarie che anche indirettamente determinino la disapplicazione della suddetta regola[21], nutrendosi perplessità in tal senso anche in considerazione del rischio della violazione del divieto di frode alla legge. Ed infatti, si ritiene di dover condividere la tesi di chi ha sostenuto che la sottoscrizione del verbale da parte del presidente e del notaio – che del documento sono entrambi “coautori” - non costituisce un elemento del procedimento assembleare passibile di diretta o indiretta diversa regolamentazione statutaria, come traspare inequivocabilmente dalla lettera dell’art. 2379, comma 3, ultima parte, c.c. che disciplina la nullità del verbale e stabilisce che il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell’assemblea, o dal presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o (in aggiunta e non in sostituzione del presidente) dal notaio. E ciò a conferma che il verbale dell’assemblea debba essere in ogni caso sottoscritto oltre che dal notaio anche da un soggetto portatore dell’interesse dell’ente; soggetti tutti che, avendo partecipato ai lavori assembleari ed essendo portatori dell’interesse dell’ente alla corretta verbalizzazione, svolgono in via alternativa tale funzione anche al fine di evitare una delle potenziali cause di invalidità[22].
Del resto, la volontà del legislatore di valorizzare il ruolo della sottoscrizione del verbale da parte di entrambi i suoi “coautori” risulta anche dalle recenti modifiche all’art. 66 delle disposizioni di attuazioni al codice civile che, nel regolamentare espressamente lo svolgimento in modalità telematica delle assemblee di condominio, da un lato non lascia la scelta all’arbitrio dell’amministratore e dall’altro, prevede espressamente che il verbale venga sottoscritto sia dal presidente che del segretario[23].
Le conclusioni sopra ipotizzate in merito alla necessità della sottoscrizione del verbale di assemblea da parte del presidente si riverberano inevitabilmente sul tema molto controverso della legittimità a regime dello svolgimento di assemblee di società totalmente in videoconferenza, ossia senza la presenza fisica del presidente nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, in ipotesi anche il notaio. Si deve, pertanto, coerentemente escludere che questa modalità di svolgimento delle assemblee dei soci di società di capitali, non regolata dal codice civile e riconosciuta solo nel periodo “Covid” con disposizione emergenziale ed eccezionale contenuta nel citato art. 106, D.L. n. 18/2020, e successive proroghe, sia legittima “a regime” a nulla rilevando neppure la previsione di specifica clausola statutaria[24]. La tesi positiva, pur autorevolmente sostenuta[25], non può essere condivisa perché ogni riflessione che coinvolga il tema della sottoscrizione del presidente dell’assemblea va contestualizzata nel sistema normativo che attribuisce la funzione della verbalizzazione al notaio, con conseguente applicazione delle regole espresse per la sua esplicazione sia dal codice civile che dalla legge notarile, e quindi considerando il carattere indisponibile dell’interesse pubblicistico alla confezione di un verbale che sia valido e sostanzialmente riconducibile ai requisiti previsti per l’atto pubblico dall’art. 2700 c.c. e dalla legge notarile, oltre che le criticità derivanti dalla combinazione di questa nuova “modalità” di svolgimento dell’assemblea con i principi dell’ordinamento che tutelano l’interesse del socio alla partecipazione personale ai lavori assembleari, con le regole dettate dal codice civile sul luogo di convocazione, e con i principi civilistici per il perfezionamento di atti di natura negoziale eventualmente collegati alla verbalizzazione. In particolare, con riferimento alla presunta irrilevanza del luogo di convocazione, non sembra giustificata, in mancanza di espressa disposizione normativa, la disapplicazione delle norme che ne prevedono l’indicazione nell’avviso di convocazione dell’assemblea in forma totalmente telematica[26] ed appare difficile, se non impossibile, fare ricorso a figure elaborate in dottrina quale “il luogo virtuale”[27] che nella fattispecie sostituirebbe il luogo fisico dello svolgimento dei lavori assembleari. Questo aspetto non sembra superabile con l’introduzione di una clausola statutaria che preveda la possibilità dello svolgimento delle assemblee in modalità “totalmente a distanza” poiché la disciplina relativa al luogo di convocazione non è stata derogata dal codice civile, né per le s.r.l. né per le s.p.a., neppure per la formulazione della clausola statutaria di assemblea da svolgere con strumenti informatici per come già presente nel codice civile anteriormente alla sopra citata legislazione emergenziale.
Si precisa che la necessità della sottoscrizione del presidente oltre che del segretario/notaio prescinde dalla contestualità o meno della verbalizzazione poiché, la previsione contenuta nello stesso art. 2375, ultimo comma, c.c. della c.d. verbalizzazione non contestuale, ossia successiva allo svolgimento dei lavori ma nei termini per l’esecuzione degli obblighi “di deposito o pubblicazione”, non reca dal punto di vista letterale alcuna deroga al principio sancito al comma primo dell’art. 2375 c.c., in guisa che in mancanza di sottoscrizione da parte del presidente si riproporrebbe il problema della confezione di un verbale potenzialmente invalido poiché non coperto dal meccanismo sanante di cui all’art. 2379, comma 3, ultima parte, c.c.
La sottoscrizione del presidente oltre che del notaio elimina a monte una delle ipotesi per cui un verbale può essere considerato mancante e quindi elimina una delle ipotesi di invalidità dello stesso, come si desume in tema di s.p.a. dall’art. 2379, comma 3, ultima parte, c.c. che individua nella mancanza del verbale una delle cause di nullità e stabilisce che il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell’assemblea, o dal presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza[28] e dal segretario o dal notaio (in aggiunta e non in sostituzione del presidente, come sopra detto)[29]. Questa norma delinea un meccanismo di sterilizzazione della patologia del verbale e concepisce la figura del notaio come sostitutiva del solo segretario e non anche del presidente, così confermando i principi declinati dall’art. 2371, comma 2, c.c. e dall’art. 2375 c.c., e accentuando la funzione antiprocessuale della verbalizzazione notarile.
Si ritiene che lo stesso meccanismo “sanante” operi in caso di sottoscrizione del verbale da parte del presidente nelle S.r.l. poichè la disciplina dell’art. 2379 c.c. non è avulsa dal sistema di questo tipo sociale. E ciò sia in virtù di una lettura sistematica e non atomistica delle norme che disciplinano la verbalizzazione delle decisioni dei soci di S.r.l., le cui lacune possono essere colmate con il ricorso all’analogia alla disciplina della S.p.a. considerata la recente progressiva tendenza del legislatore di avvicinare questo tipo sociale alle S.p.a. sotto numerosi profili; sia in ragione del richiamo espresso contenuto nell’art. 2479-ter, comma 4, c.c. che, disciplinando l’invalidità delle decisioni dei soci della S.r.l. e rinviando in parte alla disciplina delle S.p.a., sancisce che si applica, in quanto compatibile, tra gli altri anche l’art. 2379-ter c.c., che a sua volta richiama l’art. 2379 c.c.
In conclusione, la sottoscrizione dei “coautori” del verbale[30] risulta necessaria al perfezionamento dell’atto sia in S.p.a. che in S.r.l. e, ove non vi siano le sottoscrizioni del presidente e del notaio (quando quest’ultimo funge da segretario) il verbale potrebbe essere affetto da invalidità, a prescindere dalla modalità contestuale o differita della verbalizzazione. Ed infatti, la previsione contenuta nello stesso art. 2375, ultimo comma, c.c. della c.d. verbalizzazione differita non declina alcuna deroga al principio sancito al comma primo dell’art. 2375 c.c., in guisa che anche nella verbalizzazione differita la mancanza di sottoscrizione da parte del presidente ripropone il rischio della confezione di un verbale potenzialmente invalido poiché non coperto dal meccanismo sanante di cui all’art. 2379, comma 3, ultima parte, c.c. Peraltro, si ritiene che sia quantomeno incoerente ammettere la verbalizzazione non contestuale per le S.r.l. sulla base del ricorso all’analogia delle norme sulla S.p.a. e nello stesso tempo escludere l’applicazione della regola declinata dall’art. 2375 c.c. che per il verbale delle S.p.a. prevede la sottoscrizione del presidente oltre che del notaio.
Posta la natura di atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c. del verbale redatto da notaio e della conseguente necessaria applicazione della legge notarile, ulteriore e decisivo argomento a sostegno della necessità della sottoscrizione del presidente risiede nel rischio che in mancanza il verbale notarile, contestuale o differito, non sia idoneo a costituire piena prova ai sensi dell’art. 2700 c.c. in quanto manchevole dei requisiti previsti per la sua confezione. Si tratterebbe, sia per le s.p.a. che per le s.r.l., di un documento nato potenzialmente “invalido” in base al combinato disposto degli artt. 2375, comma 1 e 2379, comma 3, ultima parte, c.c.[31] e dell’art. 51 l. not., rispetto al quale la qualifica soggettiva del suo unico sottoscrittore (rectius: il notaio) non sembra sia di per sé sufficiente a superare il dubbio sulla possibilità di qualificare il verbale come atto pubblico ai fini dell’art. 2700 c.c.
Se la prospettiva esegetica partisse dal diverso presupposto che il soggetto dichiarante, ossia il presidente, non è parte del verbale né ai sensi dell’art. 51 l. not. né agli effetti dell’art. 2700 c.c. si arriverebbe a sostenere che il verbale di assemblea rientri nella c.d. categoria degli atti di constatazione, la cui valenza probatoria ai fini dell’art. 2700 c.c. è tutt’altro che pacifica[32].
Il verbale, contestuale o differito, sottoscritto dal solo notaio, non potrebbe, peraltro, mai essere considerato sotto il profilo civilistico idoneo documento per le fasi negoziali in senso stretto collegate alla deliberazione, quali ad esempio conferimenti in natura o qualsiasi altra dichiarazione dei soci incidente su diritti soggettivi, poiché si tratterebbe di dichiarazioni sempre prive della sottoscrizione del loro autore (rectius: della parte) e quindi prive di un elemento essenziale ai fini del perfezionamento della fattispecie. Problema, questo, che si pone non solo a “regime” nella sopra richiamata ipotetica ricostruzione del verbale “senza parte” sottoscritto dal solo notaio[33] ma anche in base alla legislazione emergenziale in quanto non v’è neppure in quest’ultima né nelle sue successive proroghe una deroga ai principi civilistici che regolano il perfezionamento degli atti negoziali ancorché contenuti in verbali assembleari, disposizioni negoziali, che ove presenti, sono difficilmente scindibili in concreto dalla verbalizzazione in senso stretto e collegate funzionalmente alla deliberazione e al suo documento da prassi redazionali notarili consolidate.
[1] Cfr. Studio n. 41/2023, La riunione assembleare a distanza, estensori G. Ferri jr - J. Sodi, Approvato dalla Commissione Studi di Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato, ivi ult. rif., pubblicato in CNN notizie quale contributo scientifico ma con l’apposizione di un “caveat” del seguente tenore letterale: “Il Consiglio Nazionale nella seduta del 21 luglio 2023 ha deliberato all’unanimità di pubblicare lo studio quale contributo scientifico evidenziando, tuttavia, che le soluzioni operative proposte in ordine:
- a) alla indicazione o meno del luogo fisico di convocazione e svolgimento delle adunanze;
- b) alla necessità o meno della compresenza del presidente e del notaio verbalizzante nel medesimo luogo fisico, non essendo supportate, a oggi, da un chiaro quadro normativo e giurisprudenziale, vanno valutate, nell’operatività quotidiana, con l’indispensabile prudente apprezzamento di ciascun notaio.
La presente delibera deve considerarsi corredo essenziale e necessario del contributo scientifico che segue.”.
[2] Cfr. Studio n. 41/2023, La riunione assembleare a distanza, estensori G. Ferri jr - J. Sodi, Approvato dalla Commissione Studi di Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., ivi ult. rif. Sembra opportuno rilevare che anche la CONSOB si è espressa in senso contrario all’ammissibilità di clausole statutarie che, in mancanza di proroga della legislazione emergenziale, consentano lo svolgimento di assemblee di società di capitali in modalità “virtuale” con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-07579, tesi riportata e ribadita da A. Allotti - P. Spadola, in Gli sviluppi tecnologici del diritto societario, a cura di Bianchini - Gasparri - Trovatore - Zoppini, Quaderni giuridici n. 23, maggio 2022, CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Roma, 2022, p. 48 ss., in particolare pp. 48-49, testo e nota 17.
[3] L’art. 66 disposizioni di attuazione del codice civile, da un lato prevede a determinate condizioni la possibilità che l’assemblea si svolga in modalità telematica anche ove non sia “espressamente previsto nel regolamento condominiale, ma dall’altro impone la sottoscrizione del verbale da parte del presidente: “[…]Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. […]”.
[4] Sembra altresì opportuno rilevare, sotto il profilo della tutela dei diritti dei soci, come la Commissione Europea ha recentemente inviato all’Italia una lettera di infrazione “INFR(2025)4004” dalla quale emerge il non corretto recepimento della direttiva 2007/36/CE sui diritti degli azionisti, e in particolare il diritto degli azionisti di scegliere senza limitazione il proprio rappresentante per le assemblee generali. Sul tema, cfr. Assemblee societarie da remoto, Italia in mora, in Italia Oggi, 15 maggio 2025, 22, p. 4.
[5] Per un resoconto del dibattito, cfr. Studio n. 41/2023, La riunione assembleare a distanza, estensori G. Ferri jr - J. Sodi, cit., ivi ult. rif. bibliografici; e M. Bianca - O. Cagnasso - C.F. Giuliani - G. M. Miceli, Il presidente dell’assemblea tra codice civile, legge notarile e legislazione emergenziale, in Il Nuovo Diritto delle Società, 2025, 3, p. 409 ss., ivi ult. rif. bibliografici.
[6] Per una disamina del tema del rapporto della centralità ed autonomia delle rispettive funzioni del presidente e del segretario nella verbalizzazione delle riunioni delle assemblee e degli altri organi collegiali e del rispettivo ruolo nella creazione del documento da intendere come il risultato della necessaria cooperazione di entrambi per come concepita dal codice civile, cfr. e M. Bianca - O. Cagnasso - C.F. Giuliani - G. M. Miceli, Il presidente dell’assemblea tra codice civile, legge notarile e legislazione emergenziale, cit., pp. 427 – 429, e in particolare pp. 429 ss. per la funzione del presidente, ivi ulteriori riferimenti bibliografici. Vedi anche infra nota n. 9.
[7] E ciò in considerazione sia del dato letterale dell’art. 2375, comma 2, c.c. collegato con l’art. 2699 c.c., sia della previsione dell’art. 2332 c.c. che tra le cause di nullità della società prevede al numero “1)” la “mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico”, nonchè per il principio di simmetria delle forme che non può non estendersi anche alle modifiche dell’atto costitutivo/statuto; ed inoltre per il tenore dell’art. 2421, n. 3, c.c. che prevede la trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee “[...] dei verbali redatti per atto pubblico [...]”. Sembra opportuno ricordare che il codice del 1942 nell’art. 2699 definisce l’atto pubblico come quello redatto da notaio, a differenza dell’art. 1315 c.c. abrogato che lo definiva come l’atto ricevuto dal notaio; sottolinea il rilievo della differenza, F. Gerbo, Voce: Documento, Diritto Civile, Milano, 2011, p. 681. Sul concetto di sottoscrizione dell’atto pubblico, F. Carnelutti, Studi sulla sottoscrizione, in Riv. dir. comm., 1929, XXVII, parte I, pp. 34 ss.; A. Lener, Atto pubblico e sottoscrizione delle parti, Spunti circa il significato della forma solenne, in Riv. not., 1978, I, pp. 988 ss.; S. Patti, Le prove, in Trattato dir. priv., a cura di G. Iudica - P. Zatti, Milano, 2021, pp. 446 ss.
[8] Si riporta il testo dell’ art. 60 della legge notarile: “Art. 60 Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Codice civile, nel Codice di procedura civile o in qualunque altra legge del Regno, ma le completino.”.
[9] I poteri del segretario sono delineati dal legislatore che lo considera soggetto essenziale nella S.p.a. (e si ritiene per analogia anche nella s.r.l.), e gli attribuisce funzioni di “assistenza” del presidente di natura “organizzativa” e di cooperazione. Questi poteri trovano il loro fondamento nell’art. 2371 c.c. e la concreta enucleazione in base alle richieste del presidente, e pongono il segretario in una posizione ausiliaria, pur rimanendo ferma la specificità della funzione ove la verbalizzazione avvenga a ministero di notaio. Sul tema dei poteri del segretario, v. F. Massa Felsani, Il ruolo del presidente nell’assemblea delle S.p.a., cit., pp.139 ss.; S. Alagna, Il presidente dell’assemblea nella società per azioni, cit., p. 183.
[10] Giova rilevare come la lettura “semantica” dell’art. 2375 c.c. sul ruolo del presidente e del segretario ovvero del presidente e del notaio qualora la verbalizzazione avvenga a suo ministero, è stata tenuta presente, sia pure nella opposta prospettiva derogatoria al principio della compresenza, proprio dalla legislazione emergenziale che, nel suo tenore letterale non sembra lasciare dubbi. Cfr. art. 106, n. 2, d. l. n. 18/2020: […] senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. […]”.
[11] In tal senso anche L. Nazzicone, Assemblea, cit., p. 134, ove si afferma che l’art. 2375 c.c. va letto “in connessione” con l’art. 2371 c.c. che contempla la figura del presidente dell’assemblea e del segretario, “stabilendo che il secondo” (rectius: il segretario) “non occorre quando il verbale è redatto da notaio”.
[12] Norma che si ritiene rappresenti sedes materiae l’applicazione del principio di compresenza sancito dall’art. 51 l. not. anche alle deliberazioni assembleari ove il notaio funga da segretario.
[13] Pur nella specificità del ruolo e delle rispettive funzioni per come sopra precisato.
[14] Ai fini che qui rilevano, si evidenzia che per la S.r.l. le problematiche relative alla verbalizzazione sono più ampie e derivano dalla frammentarietà della disciplina che ha fatto dubitare taluni anche della necessità della verbalizzazione. Tuttavia, sembra opportuno ricordare che, quando la decisione ha ad oggetto una modifica statutaria, la necessità della verbalizzazione discende dal necessario ed imprescindibile coordinamento tra la lettera degli artt. 2479-bis, comma 3, ultima parte, 2479-ter, comma 4, e 2480 c.c. con l’art. 51 l. not. La sintassi dell’art. 2480 c.c.:
- richiamando la figura del notaio quale soggetto verbalizzante porta con sé, senza riduzioni di sorta, l’applicazione della legge notarile oltre che lo specifico controllo omologatorio;
- richiamando l’art. 2479-bis c.c., riconosce anche in questo tipo sociale non solo l’essenzialità della verbalizzazione ma anche il ruolo centrale del presidente dell’assemblea, le cui funzioni coincidono con quelle previste per il presidente dell’assemblea di S.p.a. per come delineate dall’art. 2479-bis, comma 4, c.c., nonché in virtù dell’art. 2479-ter, comma 4, c.c. che richiama l’art. 2379-ter c.c. che a sua volta richiama l’art. 2379, che al comma 3 prevede l’esclusione di una causa di nullità del verbale in presenza della firma del presidente oltre che del segretario. Con riferimento a quest’ultimo profilo, da un lato, l’art. 2479-bis, comma 4, ultima parte, c.c. prevede che “[...] degli esiti degli accertamenti deve essere dato conto nel verbale” e quindi il momento della verbalizzazione è espressamente previsto come essenziale e tendenzialmente non derogabile anche nella S.r.l.; dall’altro, l’art. 2479-bis, comma 4, primo periodo, c.c. declina i poteri del presidente e non ne delinea un ruolo “ridotto” rispetto al momento della verbalizzazione delle decisioni dei soci di S.r.l. che possa giustificare l’irrilevanza della sua sottoscrizione sotto il profilo dell’invalidità e della valenza probatoria del documento. Invero, a questo fine non rileva la mancanza nella S.r.l. di una norma che riproduca espressamente il meccanismo “sanante” dell’art. 2379, comma 3, c.c. poiché questa norma, come detto, non è avulsa dal sistema della S.r.l. per il richiamo effettuato dall’art. 2479-ter, comma 4, c.c. all’art. 2379-ter c.c., che a sua volta richiama l’art. 2379 c.c.
[15] L. Nazzicone, Assemblea, cit., pp. 222-223. In giurisprudenza, la mancata sottoscrizione del verbale da parte del presidente dell’assemblea è considerata causa di nullità, da Cass. 7 ottobre 1963, n. 198, in Foro it., 1963, I, p. 2203; Trib. Bari 9 giugno 1975, in Riv. not., 1976, p.1452; Trib. Modena 13 settembre 1987, in Giur. it., 1989, II, p. 826; Trib. Cosenza 13 luglio 1992, in Le società, 1993, p. 77 e in Riv. dir. comm., 1993, II, p.119; e per la necessità della sottoscrizione del presidente anche nel verbale non notarile, Trib. Vicenza 27 aprile 2004, in Giur. comm., 2006, II, p. 729. La firma del presidente dell’assemblea è considerata formalità necessaria ai sensi dell’art. 2379 c.c. anche da F. Massa Felsani, Il ruolo del presidente nell’assemblea delle S.p.a., cit.; S. Alagna, Il presidente dell’assemblea nella società per azioni, cit., pp.182-188; L. Nazzicone, Assemblea, cit., p. 134; A. Stagno d’ Alcontres, L’invalidità delle deliberazioni dell’assemblea di S.p.a.. La nuova disciplina, in Il Nuovo Diritto delle Società - Liber Amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, Assemblea – Amministrazione, vol. 2, Milano, 2006, p. 205; cfr. anche F. Laurini, Commento all’art. 2375 c.c., in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti - Bianchi - Ghezzi - Notari, Assemblea, a cura di Picciau, Milano, 2008, pp. 222-223; M. Bianca – O. Cagnasso – C.F. Giuliani – G. M. Miceli, Il presidente dell’assemblea tra codice civile, legge notarile e legislazione emergenziale, cit., pp. 434 ss.; contra, G. Rescio, Problemi in tema di verbale assembleare, p. 853; F. Magliulo, Sub 138 bis, in AA.VV., La legge notarile, a cura di P. Boero - M. Ieva, Milano, 2014, p. 753 ss.; ID, La sottoscrizione del verbale assembleare notarile: un ritorno al passato?, in Notariato, 4, 2025, p. 1 ss.; M. Maltoni, M. Notari, P. Talice, Verbali societari e firma del presidente: nihil novum sub sole, in Riv. not., 4, agosto 2025, p. 655 ss.; Consiglio Notarile di Milano, Massima n. VIII, Redazione non contestuale del verbale assembleare (art. 2375 c.c.), 3 luglio 2001; ID, Massima n. 45, Tempi e regole per la formazione del verbale di assemblea (art. 2375 c.c.), 19 novembre 2004, entrambe in www.consiglionotarilemilano.it; Massima della Commissione Massime Triveneto – numero A.A.12 del 9-2023.
[16] Ricostruzione che risulta coerente con gli elementi del procedimento collegiale quale modo di formazione della dichiarazione di volontà della maggioranza assembleare. Sul tema, v. A. Venditti, Collegialità e maggioranza nelle società di persone, Napoli, 2015, Ristampa, pp. 37 ss.
[17] Sul tema, L. Nazzicone, Assemblea, cit., p. 134, ove si afferma che “[...] Il verbale notarile, per la tesi preferibile, va sottoscritto anche dal presidente dell’assemblea, come sembra in modo inequivoco indicare l’art. 2379, comma 3, c.c. [...]”. In senso contrario, Consiglio Notarile di Milano, Massima n. VIII, Redazione non contestuale del verbale assembleare (art. 2375 c.c.), 3 luglio 2001; ID, Massima n. 45, Tempi e regole per la formazione del verbale di assemblea (art. 2375 c.c.), 19 novembre 2004, entrambe in www.consiglionotarilemilano.it
[18] Cfr., ex multis, F. Magliulo, Sub 138 bis, cit., pp.753 ss.; G. Rescio, Problemi in tema di verbale assembleare, cit., p. 853; G. Casu, L’atto notarile tra forma e sostanza, Roma, 1996, p. 761.
[19] Cfr. N. Abriani, Sul verbale assembleare non contestuale di società di capitali, cit., ivi ul. rif.
[20] Cfr. N. Abriani, Sul verbale assembleare non contestuale di società di capitali, cit., ivi ul. rif.
[21] Sul tema della previsione statutaria dello svolgimento delle assemblee in modalità totalmente a distanza, cfr. Studio n. 41/2023, La riunione assembleare a distanza, estensori G. Ferri jr - J. Sodi, cit., testo e note n. 2 e n. 3, ivi ult. rif.
[22] Per l’applicazione della norma anche ove a sottoscrivere il verbale sia l’amministratore unico, A. Stagno d’Alcontres, L’invalidità delle deliberazioni dell’assemblea di S.p.a.. La nuova disciplina, in Il Nuovo Diritto delle Società - Liber Amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, Assemblea – Amministrazione, vol. 2, Milano, 2006, p. 205. Sul tema, cfr. anche F. Guerrera, Il verbale di assemblea, in op. ult. cit., pp. 113-114, e in particolare p.114 nota 74.
[23] Cfr. art. art. 66 disposizioni di attuazione del codice civile.
[24] Giova rilevare che il legislatore ha voluto questa modalità di svolgimento dei lavori assembleari, anche a regime, specificamente e solo per le associazioni e fondazioni all’art. 24, comma 4, del Codice del Terzo Settore, “Salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente […]”, riconoscendo quindi espressamente la rilevanza della scelta contraria in funzione dell’intervento alla riunione e dell’esercizio del diritto di voto in presenza.
[25] Cfr. Studio n. 41/2023, estensori G. Ferri jr - J. Sodi, cit., ivi ult. rif.; in senso analogo L. Schiuma, Assemblea: il procedimento, in Aa. Vv., Milano, 2025, pp.1028 - 1031. In senso contrario all’ammissibilità di clausole statutarie di tal tipo, v. la risposta CONSOB all’interrogazione parlamentare n. 5-07579, tesi riportata e ribadita da A. Allotti - P. Spadola, in Gli sviluppi tecnologici del diritto societario, a cura di Bianchini - Gasparri - Trovatore - Zoppini, cit., p. 48 ss., in particolare pp. 48-49, testo e nota 17.
[26] Sul tema del luogo “virtuale” della convocazione nelle assemblee telematiche, cfr. L. Schiuma, Assemblea: il procedimento, cit., pp. 928-929. Per il concetto di luogo di convocazione nelle s.r.l., cfr. M. Cian, Le decisioni assembleari, cit., pp.1367-1368.
[27] Per l’ammissibilità, di recente, L. Schiuma, op. ult. cit.
[28] Si conferma quindi che il verbale dell’assemblea debba essere in ogni caso sottoscritto oltre che dal notaio anche da un soggetto portatore dell’interesse dell’ente, sia esso il presidente dell’assemblea, sia esso il presidente del c.d.a. o sia esso il presidente del consiglio di sorveglianza ex art. 2406 in virtù del testuale richiamo dell’art. 2409 quaterdecies, comma 1 c.c.; soggetti che, avendo partecipato ai lavori assembleari ed essendo portatori dell’interesse dell’ente alla corretta verbalizzazione, svolgono in via alternativa tale funzione anche al fine di evitare una delle potenziali cause di invalidità. Si evidenzia che secondo un condivisibile orientamento di pensiero la norma troverebbe applicazione anche ove a sottoscrivere il verbale sia l’amministratore unico. In tal senso, A. Stagno d’ Alcontres, L’invalidità delle deliberazioni dell’assemblea di S.p.a.. La nuova disciplina, cit., p. 205. Sul tema, cfr. anche F. Guerrera, Il verbale di assemblea, pp. 113-114, e in particolare p.114 nota 74.
[29] Ancora in tal senso sembra esprimersi A. Stagno d’ Alcontres, L’invalidità delle deliberazioni dell’assemblea di S.p.a.. La nuova disciplina, cit., p. 205.
[30] Cfr. F. Massa Felsani, Il ruolo del presidente nell’assemblea delle S.p.a., cit., p.132; G. Rescio, Problemi in tema di verbale, cit., p. 859.
[31] Sul tema dell’efficacia probatoria dell’atto pubblico, C.M. Bianca, Il contratto, cit., pp. 267 ss.; S. Patti, Le prove, cit., pp. 452 ss.; G. Ghiberti, L’atto pubblico: profili sostanziali e processuali, in I Contratti in generale, VII, Forma - Atto Pubblico Scrittura privata - Firma digitale, in P. Cendon (a cura di), Il diritto privato nella giurisprudenza, Torino, 2000, pp. 95 ss.; E. Tommaseo, L’atto pubblico notarile nel sistema delle prove documentali, in Riv. not., 1998, pp. 593 ss.; sulle potenziali ricadute sulla funzione “antiprocessuale” del notaio, cfr. F. Carnelutti, La figura giuridica del notaro, cit., pp. 921 ss.; Id., Diritto o arte notarile, cit., pp. 223 ss.
[32] Cfr. L. Nazzicone, Assemblea, cit., p. 132 ss.; in giurisprudenza, sul tema della valenza probatoria del verbale, la sentenza Cass. Civ., Sez. I, n. 560 del 2001. Considera non necessaria la sottoscrizione del presidente dell’assemblea sostenendo che il verbale rientri nella categoria degli atti “di constatazione” la Massima della Commissione Massime Triveneto – numero A.A.12 del 9-2023, ove si afferma che: “La particolare efficacia probatoria prevista dall’art. 2700 c.c. di detti atti, infatti, è riferita unicamente alle attestazioni fatte dal pubblico ufficiale”.
[33] Come peraltro escluso anche dai sostenitori della ammissibilità del verbale totalmente a distanza a regime. Cfr. Studio n. 41/2023, estensori G. Ferri jr - J Sodi, cit., ivi ult. rif.
Massime anno 2024
Commissione Massime di Diritto Societario – Consiglio Notarile di Roma
(approvata il 18 luglio 2024)
Società a responsabilità limitata semplificata. Acquisto della partecipazione sociale da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 2463 bis c.c.)
La titolarità delle quote di partecipazione ad una s.r.l. semplificata può intestarsi, a mezzo circolazione durante societate, su enti; in tal caso, la società perde la qualifica di “semplificata” e diventa soggetta all’applicazione esclusiva ed integrale della disciplina della s.r.l., c.d. a capitale esiguo o non, ciò dipendendo dal quantum di capitale sociale destinato.
In assenza di una previa o contestuale modifica in s.r.l., c.d. a capitale esiguo o non, l’atto di trasferimento di quota di partecipazione ad una s.r.l. semplificata a favore di un ente risulta valido, ma produce effetti immediati solo tra le parti e non nei confronti dei terzi. Tale trasferimento, effettuato senza la previa o contestuale modifica societaria, può avere eccezionalmente una rilevanza non solo tra le parti ma anche verso la società, ove lo stesso venga comunque iscritto al Registro delle Imprese; in questo caso alla delibera di recepimento formale della intervenuta modifica societaria sarà legittimato ad intervenire e votare il rappresentante dell’ente cessionario.
MOTIVAZIONE
L’art. 2463 bis, comma 1, c.c. dispone che «la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche».
Il legislatore non ha affrontato il problema dell’“ingresso” in una società a responsabilità limitata semplificata, posteriore alla sua costituzione, di persone giuridiche o comunque di enti.
Concentriamo la nostra analisi sulla fattispecie che può presentarsi con maggiore frequenza, costituita dall’ingresso di un ente in una s.r.l.s., post costituzione.
È stata abrogata nel 2013 la disposizione del testo originario del comma 4 dell’art. 2463 bis c.c. che recitava: «è fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l’eventuale atto è conseguentemente nullo». La norma originaria, risalente al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, prevedeva che la s.r.l.s. potesse essere costituita solo da persone fisiche che non avessero compiuto i 35 anni di età. Ora tale abrogazione sembrerebbe prima facie deporre per l’attuale trasferibilità (non rileva se la cessione è a titolo oneroso o gratuito) a chiunque delle quote di partecipazione di s.r.l.s., dopo la sua costituzione.
La fattispecie risulta però più complessa di ciò che sembra.
Le alternative che in linea astratta si potrebbero porre sono sostanzialmente le seguenti: A) ritenere durante societate il trasferimento di quote di partecipazione di s.r.l.s. ad enti sempre valido, efficace e dunque ricevibile dal notaio; B) ritenere detto trasferimento sempre invalido ed inefficace ed in particolare nullo; C) ritenere il trasferimento in esame valido e dunque ricevibile dal notaio ma come un trasferimento che (diventa ex lege) di quota di partecipazione di s.r.l. c.d. a capitale esiguo (già definite in passato e cioè prima della legge 9 agosto 2013, n. 99, società “a capitale ridotto”) o non (qualora vi fosse, contestualmente alla cessione, un aumento di capitale ad euro 10.000,00 o più).
Non è un caso che, con il parere del 15 febbraio 2016 prot. n. 39.365, il Mi.S.E. (a seguito di un quesito formulato dalla Camera di Commercio di Ancona) sia stato espressamente investito della questione, pervenendo ad una soluzione che, in modo sibillino, ha ritenuto da un lato legittimo tale trasferimento, “in quanto il divieto contenuto nel comma 1 dell’art. 2463 bis c.c., riguarda la sola fase di costituzione della società”, ma al contempo ha poi sostanzialmente affermato che si perdono le caratteristiche di società a responsabilità limitata semplificata, assumendosi quelle di società a responsabilità limitata c.d. a capitale esiguo.
Il tema della partecipazione, post costituzione, di enti (associazioni, società, consorzi, ecc.) ad una s.r.l.s. si può presentare non solo nel caso di trasferimento (del diritto di proprietà o di nuda proprietà o anche di taluni altri diritti reali parziari compatibili con la partecipazione sociale) di quote di partecipazione, ma anche in altre operazioni cc.dd. di mercato primario o straordinarie.
Si pensi ad esempio al caso di un aumento di capitale, nei limiti concessi dalla soglia massima inferiore ad euro 10.000,00, che consenta la collocazione dell’inoptato presso terzi ai sensi dell’art. 2481 bis, co. 1, c.c.: la collocazione dell’inoptato in favore di terzi permette infatti, al pari della circolazione con operazione c.d. di mercato secondario, l’ingresso in società di nuovi soci che potrebbero non possedere i requisiti soggettivi previsti dalla legge. Un altro esempio è costituito dall’esito di operazioni straordinarie (ad esempio di fusioni, scissioni, ecc.) che “sfocino” in s.r.l.s. partecipate proprio da enti, sempre che si ritenga lecita quest’ultima forma societaria quale approdo finale dell’operazione [così ad esempio, Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 132 del 5 marzo 2013, Modificazioni statutarie e "trasformazione" di s.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463-bis c.c. e art. 44 d.l. 83/2012); contra Tassinari, “Ne sexies in idem”: la ricerca del legislatore italiano di semplificare la costituzione delle srl., in Soc. contr., 9/2013, p. 21].
La questione si pone pertanto per ogni ipotesi da cui consegua volontariamente l’attribuzione di una quota di partecipazione di s.r.l.s. in favore di una persona giuridica e/o in generale di un ente.
Ebbene anticipiamo subito che non pare tuttora legittimo l’“accesso” di soggetti diversi dalle persone fisiche ad una società a responsabilità limitata semplificata: a fortiori se successivo alla costituzione [contra, però, SPOLIDORO, Unica società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?), in Riv. soc., 2013, p. 1097 e p. 1109]; tuttavia l’eventuale trasferimento della quota in parola all’ente resta, come vedremo, valido ed efficace fin da subito tra le parti (seppure da considerare, per le ragioni dette, come di quota di s.r.l. a capitale marginale).
La tesi della nullità di tale trasferimento poteva essere sostenuta in passato, in base all’applicazione analogica della norma che statuiva tale sanzione per il trasferimento ad un soggetto avente età anagrafica superiore a quella consentita, ma oggi, dopo l’abrogazione di detta norma, di certo non può più essere condivisa.
L’opinione di chi scrive è dunque a favore della tesi in precedenza indicata sub C): il trasferimento di quota di partecipazione di s.r.l.s. ad un ente è valido e ricevibile dal notaio ma si “converte” (o meglio si “qualifica” tramite l’attività interpretativa di individuazione dell’esatta natura giuridica dell’atto) in un trasferimento di quota di partecipazione di s.r.l. c.d. a capitale esiguo o non, sulla base del quantum di capitale sociale destinato.
Depone in tale senso la ratio della normativa che ha introdotto le s.r.l.s., la quale, concedendo in via eccezionale una serie di agevolazioni sul piano fiscale ed amministrativo e prevedendo sempre in via straordinaria la gratuità della prestazione professionale del notaio, ha inteso favorire inizialmente l’accesso all’attività imprenditoriale dei giovani (quando in origine esisteva il limite anagrafico dei 35 anni per potervi partecipare) e poi delle altre fasce di persone per così dire socialmente deboli. Si è avuto sostanzialmente di mira un favor per l’imprenditoria cosiddetta di primo livello (cfr. BARTOLACELLI, L’insostenibile leggerezza dell’s.r.l.s., relazione al Convegno annuale dell’associazione italiana dei professori universitari di diritto commerciale Orizzonti del diritto commerciale, tema L’impresa e il diritto commerciale: innovazione, creazione di valore, salvaguardia del valore nella crisi, svoltosi a Roma, 21-22 febbraio 2014): quella che non gode già delle agevolazioni della responsabilità limitata tipiche delle società di capitali. L’idea di fondo era infatti che il beneficio della responsabilità limitata producesse generalmente effetti positivi sul sistema economico e produttivo nel suo complesso e così giustificasse il progressivo snellimento degli oneri della procedura costitutiva di questo tipo di società. Essendo questa la ratio indubbia della normativa che ha introdotto le s.r.l.s. con le note agevolazioni (semplificazioni amministrative, esenzioni fiscali e gratuità della prestazione notarile) nel nostro sistema giuridico, la stessa non può che essere interpretata in senso restrittivo, giacché norma eccezionale, non estensibile a fattispecie diverse rispetto a quella a cui si riferisce.
Va quindi ribadito che il trasferimento della quota di partecipazione di s.r.l.s. a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche non è tuttora consentito sic et simpliciter. D’altra parte, in caso contrario verrebbe frustrata la stessa previsione della costituzione iniziale necessariamente riservata a favore di persone fisiche, consentendosi così la pratica elusiva di costituire dapprima la società a responsabilità limitata semplificata, tramite ad esempio uno o più prestanomi persone fisiche, per poi trasferire immediatamente dopo le partecipazioni sociali della stessa a soggetti non autorizzati nella fase costitutiva. Il che rappresenterebbe per chi volesse aggirare la normativa de qua un indubbio vantaggio economico dato dal minore costo del trasferimento di partecipazione sociali notarile (costo che sarebbe ancor più contenuto, ove il trasferimento fosse ricevuto non dal notaio ma sottoscritto con firma digitale tramite intermediari abilitati alla presentazione in camera di commercio, come ad esempio un commercialista), seppur sommato alle spese di costituzione della s.r.l.s., rispetto al costo della costituzione ab initio di una s.r.l. In altri termini costituire fraudolentemente una s.r.l.s. e subito dopo effettuare un trasferimento di partecipazione sociale in favore di un ente, tramite per esempio un commercialista abilitato, costerebbe sempre meno che costituire da subito “a prezzo pieno” una s.r.l. c.d. a capitale esiguo o anche una s.r.l. ordinaria con capitale sociale minimo di 10.000,00 euro. La pratica elusiva potrebbe essere condotta all’estremo, se il trasferimento della partecipazione venisse per ipotesi effettuato, subito dopo l’atto costitutivo della s.r.l.s., ma ancor prima dell’iscrizione di quest’ultimo nel competente Registro delle imprese.
L’intento normativo di circoscrivere le agevolazioni e le semplificazioni previste dalla legge a determinati soggetti ed in una determinata fase, quella costitutiva, dell’impresa in sviluppo sarebbe, come detto, facilmente aggirato, mediante successivi atti diretti volontariamente a determinare l’ingresso in società di soggetti “non agevolabili”.
Il poter essere soci di s.r.l.s. per le sole persone fisiche, anche ove fosse ritenuto retaggio della prima formulazione della norma premiale per gli infra-trentacinquenni (requisito che naturalmente non poteva essere posseduto da soggetti non persone fisiche), resta, per quanto sopra evidenziato, tuttora sensato ed attuale anche dopo l’abrogazione del requisito dell’età anagrafica, altrimenti venendosi a snaturare la detta ratio e la peculiarità della s.r.l.s. La conclusione, cui si è pervenuti per il trasferimento, va estesa agli aumenti di capitale ed alle operazioni straordinarie, indicati in precedenza, nonché sostanzialmente ad ogni altro atto volontario che consenta ad un soggetto sprovvisto dei requisiti soggettivi (di persona fisica) di divenire socio di una s.r.l.s.
La soluzione non muta neppure per la s.r.l.s. costituita on line in base alla recente normativa (art. 2 comma 3 del decreto legislativo dell’8 novembre 2021, n. 183, che è stato reso attuativo dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 luglio 2022, n. 155, in vigore dal 5 novembre 2022). Anche in tale ipotesi la costituzione è sempre espressamente riservata alle sole persone fisiche e, pur cambiando, seppure parzialmente, il modello uniforme ministeriale rispetto a quello previsto per la costituzione per atto pubblico notarile analogico, non prevedendosi più la gratuità assoluta della prestazione notarile, restano comunque le agevolazioni fiscali e quindi la necessità di interpretare la normativa in senso restrittivo, poiché eccezionale (sul tema, BOGGIALI, La costituzione on line di S.r.l. e S.r.l.s. con modello standard, in Focus e Novità normative del CNN del 16 dicembre 2022).
Quanto sostenuto non equivale però ad affermare che esista un divieto assoluto per il notaio di ricevere atti di trasferimento di partecipazioni di s.r.l.s. a favore di società e/o altri enti (né similmente di ricevere operazioni di aumento di capitale oppure straordinarie che conducano al medesimo risultato finale): il trasferimento in parola non può essere di certo ritenuto nullo, visto che la sanzione della nullità è un rimedio straordinario, a maggior ragione dopo l’abrogazione dell’ex quarto comma dell’art. 2463 bis c.c. e considerata altresì l’assenza di disposizioni imperative rispetto alle quali possa dimostrarsi la contrarietà dell’atto. Significa piuttosto che l’accesso a detta società da parte di soggetti che non siano persone fisiche comporterà automaticamente la “trasformazione” (da intendersi naturalmente in senso atecnico, non trattandosi della trasformazione di cui agli artt. 2498 e ss. c.c.) ex lege della s.r.l.s. in società a responsabilità limitata c.d. a capitale esiguo o marginale (salvo naturalmente un contestuale aumento, a titolo gratuito od a pagamento, del capitale ad un minimo di euro 10.000,00). In tal modo, anche in conformità al principio di interpretazione conservativa del negozio giuridico, andrà opportunamente apprezzata la cessione de qua.
Preventivamente o quanto meno contestualmente al trasferimento della quota di partecipazione si dovrà recepire la correlativa “modifica” societaria da s.r.l.s. a s.r.l. c.d. a capitale esiguo, con mutamento della denominazione sociale mediante l’eliminazione dell’aggettivo “semplificata” (e/o dell’eventuale acronimo “S.R.L.S.”) ed inserimento della disciplina statutaria in tema appunto di s.r.l. c.d. a capitale esiguo (salva naturalmente la contemporanea delibera di aumento del capitale sociale a 10.000 euro oppure ad una cifra superiore a detto importo).
Da un punto di vista logico, se non cronologico, il suggerimento è dunque di seguire sempre la via maestra del preventivo (o almeno contestuale) adeguamento societario in s.r.l. rispetto al trasferimento della partecipazione sociale di s.r.l.s. ad un ente.
In caso contrario (mancata modifica societaria preventiva o contestuale al trasferimento), la cessione di quota di s.r.l.s. comunque resterà, come detto, valida, venendo automaticamente qualificata ex lege quale cessione di partecipazione di s.r.l. a capitale esiguo. L’atto sarà efficace immediatamente tra le parti della cessione, in attesa che venga recepita e pubblicizzata al Registro imprese la citata modifica in s.r.l. c.d. a capitale esiguo.
Del resto, la s.r.l.s. e la s.r.l. c.d. a capitale esiguo costituiscono pur sempre di varianti disciplinari del medesimo tipo societario (in termine di variante disciplinare della s.r.l., con particolare riferimento alla s.r.l.s., già ONZA, L’”accesso” alla società per azioni e alla società a responsabilità limitata, in Giur. comm., 2020, p. 728). Per effetto della cessione di quota si verrebbe a creare sostanzialmente una situazione non molto dissimile a quella che si realizza (anche lì tramite cessione/i di quota) ad esempio in caso di passaggio da s.r.l. unipersonale a s.r.l. pluripersonale o viceversa.
Che si tratti sicuramente di varianti del medesimo tipo deriva in primo luogo dalla collocazione dell’art. 2463 bis c.c. all’interno del capo VII del Titolo V del Libro V del Codice civile e cioè tra le disposizioni inerenti alla disciplina della società a responsabilità limitata ed in secondo luogo dalla struttura tipica della s.r.l.s. che comprende tutti gli elementi generali caratterizzanti la disciplina della s.r.l. e su tutti la centralità del socio (parte della dottrina predilige parlare di “sottotipo”, al posto del “variante disciplinare” del medesimo tipo: per tutti, CAGNASSO, La s.r.l: un tipo societario “senza qualità”?, in Nuovo dir. soc., 2013, 5, p. 18; M. CIAN, Il tipo s.r.l.?, in Nuove leggi civ. comm., 2021, p. 304 ss.). Depone in tale senso il richiamo, nell’ultimo comma dell’art. 2463 bis c.c., proprio alla disciplina della s.r.l. in quanto compatibile. Del resto, ove non si fosse trattato di varianti dello stesso tipo ma di tipi sociali autonomi, ogni modifica da s.r.l.s. a s.r.l. ordinaria avrebbe dovuto inquadrarsi quale trasformazione in senso tecnico e conseguentemente sarebbe stata assoggettata alla relativa disciplina: il che viene negato dalla dottrina dominante (cfr. Massima n. 132 del 5 marzo 2013 del Consiglio Notarile di Milano, cit.; Orientamento R.A.4, settembre 2012, del Comitato Triveneto dei Notai).
Tornando all’ipotesi del trasferimento di partecipazioni sociale di s.r.l.s. ad un ente effettuata senza una previa (o contestuale) modifica societaria, pur restando valida ed efficace tra le parti, determinerà a carico dell’organo amministrativo il dovere di convocare tempestivamente l’assemblea per l’adeguamento/modifica dell’atto costitutivo originario, inserendo la denominazione corretta di s.r.l. anziché di s.r.l.s. e la normativa in genere tipica della s.r.l. a capitale esiguo (in sostanza la previsione di uno “statuto” che è inesistente nella s.r.l.s.).
Inoltre, da un punto di vista professionale le parti del trasferimento andranno naturalmente rese edotte dal notaio (rogante l’atto o autenticante le firme), pena l’eventuale responsabilità professionale di quest’ultimo che, non procedendosi, prima del trasferimento o almeno contestualmente allo stesso, alla modifica in s.r.l. c.d. a capitale esiguo o non, il trasferimento sarà inizialmente efficace soltanto tra le stesse.
Per i terzi è importante conoscere se la società, con cui si rapportino, è una s.r.l.s. o una s.r.l. c.d. a capitale esiguo (oppure una s.r.l. ordinaria): ferma la valenza della pubblicità dichiarativa del trasferimento nel Registro delle imprese (di cui all’art. 2470 c.c.), l’art. 2463 bis, comma 3, c.c., impone di pubblicizzare negli atti e nella corrispondenza l’indicazione nella denominazione dell’aggettivo “semplificata”, nonché la diffusione dei dati essenziali della società anche tramite lo spazio elettronico destinato alla comunicazione e collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
Se la citata modifica societaria non venisse effettuata prima o recepita contestualmente al trasferimento de quo, il competente Registro delle imprese potrebbe rifiutarne l’iscrizione (impedendone così l’efficacia verso i terzi, arg. ex art. 2470, comma 3, c.c.); se invece il trasferimento per ipotesi fosse erroneamente iscritto, potrebbe procedere alla cancellazione d’ufficio. In entrambi i casi è comunque indubbio che l’atto di trasferimento di quota di s.r.l.s. sia valido come di quota di s.r.l. c.d. a capitale esiguo e sia efficace subito tra le parti.
D’altra parte, dopo la fase della costituzione della s.r.l.s., il confine tra quest’ultima e la s.r.l. c.d. a capitale esiguo diventa molto labile: salvo il nomen, l’unica differenza sarebbe data dalla possibilità, per la seconda variante disciplinare di società, di avere un vero atto costitutivo/statuto anziché quello “fantasma” della prima variante, di cui al modello uniforme ministeriale. Peraltro ciò sembra anche confermato dal fatto che il Legislatore nell’abrogare la s.r.l. a capitale ridotto, abbia riqualificato le società già esistenti che avevano adottato questo particolare assetto proprio come s.r.l. semplificate (cfr. art. 9, comma 15, del D.L. n. 76/2013).
La conclusione, cui si è pervenuti, sembra valere nell’ipotesi di circolazione della quota da parte dell’unico socio di s.r.l.s. o da parte di tutti i soci della stessa a favore di un ente: l’atto di trasferimento effettuato dal socio è valido come trasferimento di partecipazione sociale di s.r.l. c.d. a capitale esiguo ed efficace immediatamente tra le parti ma inefficace, fino all’iscrizione della modifica/adeguamento al registro delle imprese (che sbloccherebbe peraltro anche l’iscrizione del trasferimento), nei confronti dei terzi in genere.
Ci si potrebbe chiedere se le cose mutino nel caso in cui, in assenza di formale modifica in s.r.l. c.d. a capitale esiguo, il trasferimento in parola venga effettuato soltanto da un socio o per ipotesi da qualche socio, ma non dall’unico né dall’intera compagine sociale. In questo caso il trasferimento potrebbe esplicare effetti immediati, oltre che tra le parti della cessione, anche verso gli altri soci?
Si potrebbe eccepire che il trasferimento di partecipazione sociale di s.r.l.s. di un socio pregiudichi l’eventuale altro e/o altri soci della medesima società, i quali siano rimasti inerti, non avendo effettuato alcun trasferimento. Questi ultimi soci (gli inerti) subirebbero di fatto la citata modifica ex lege in s.r.l. c.d. a capitale esiguo determinata dal trasferimento di quota di partecipazione altrui. Sì potrebbe sostenere, in vero, che quel trasferimento, provocando un mutamento di “variante” di s.r.l. legittimi il diritto di recesso in capo agli altri soci, considerando: (i) che costoro non hanno concorso a quel mutamento; e (ii) che tale mutamento si apprezzi siccome “cambiamento del tipo”, in grado di attivare il recesso secondo l’art. 2473, comma 1, c.c., assegnando alla parola “tipo” il significato di assetto pattizio voluto dalle parti, quello di s.r.l.s., e poi mutato in altro, e diverso, assetto pattizio, quello della s.r.l. ordinaria (c.d. a capitale esiguo o non), a cagione di un comportamento del socio trasferente.
In contrario si potrebbe replicare che, trattandosi di una mera variante del medesimo tipo societario, non vi sarebbe alcun nocumento per gli altri soci (rimasti inerti) ed anzi che sarebbe ipotizzabile un miglioramento della loro situazione (si pensi, ad esempio, alla possibilità di adottare uno statuto plasmato sulle particolari esigenze dei soci, al posto del modello uniforme ministeriale di atto costitutivo, ecc.). Tanto più se si aderisse alla tesi che appare prevalente in dottrina (cfr., per tutti, FERRI Jr, La società a responsabilità limitata semplificata e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata, in Società, banche e crisi d’impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa, a cura di M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera, A. Sciarrone Alibrandi, Torino, 2014, p. 1746; IBBA, Il nuovo diritto societario tra crisi e ripresa (diritto societario quo vadis?), in Riv. soc., 2016, pp. 1049, nota 105; MARASÀ, Considerazioni sulle nuove s.r.l.: s.r.l. semplificate, s.r.l. ordinarie e start up innovative prima e dopo la L. n. 99/2013 di conversione del DL n. 76/2013, in Società, 2013, pp. 1092; TRONCI, La riserva legale a formazione accelerata: problemi vecchi e nuovi, in Riv. soc., 2014, pp. 194 ss.), secondo cui l’obbligo di formazione accelerata della riserva legale di cui all’art. 2463, ultimo comma, c.c., dettato per le s.r.l. a capitale esiguo, si applica di default anche alle s.r.l.s. In quest’ultimo senso si è sottolineato come le norme dettate in materia di s.r.l., ed a maggior ragione in tema di s.r.l. a capitale inferiore a 10.000 euro, sono generalmente tollerabili dalle s.r.l.s. e dunque a queste applicabili, stante il rinvio dell’ultimo comma dell’art. 2643 bis c.c. (anche il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n. 892/2013, ha ritenuto estensibile alle S.r.l. semplificate la speciale disciplina prevista per le s.r.l. c.d. a capitale esiguo). Del resto, la soluzione opposta comporterebbe una disparità di trattamento fra i creditori sociali delle s.r.l. c.d. a capitale esiguo o non, i quali beneficerebbero dell’applicazione della norma in commento ed i creditori sociali delle s.r.l.s., che invece non se ne potrebbero avvantaggiare.
Peraltro se anche si ritenesse non estensibile il meccanismo di formazione della riserva legale accelerata per la s.r.l.s. (per l’inapplicabilità, BUSANI, La nuova società a responsabilità limitata semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro, in Società, 2013, p. 1082; MAGLIULO, Le operazioni straordinarie nelle nuove fattispecie codicistiche di s.r.l., reperibile all’indirizzo:https://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=42/4209&mn=39; similmente MARTINO, Interrogativi in tema di patrimonializzazione delle s.r.l., con particolare riferimento alle s.r.l. semplificate, in Riv. not., 2022, pp. 353-354.), in quanto modello a carattere “promozionale”, l’eventuale svantaggio, in termini di minori utili distribuibili ai soci a causa dell’obbligo di formazione accelerata di tale riserva, potrebbe essere controbilanciato dall’utilizzo di uno “statuto” più articolato ed adeguato alle esigenze di una società ormai radicata nel mercato, nonchè da una maggiore stabilità finanziaria di quest’ultima.
Ciò riferito, coerenza e prudenza impongono di ritenere che, qualora non si raggiunga un accordo tra tutti i soci per il formale adeguamento della società (che recepisca la modifica ex lege in s.r.l. c.d. a capitale esiguo), frutto del trasferimento di quota effettuata da un solo componente della compagine, l’atto traslativo resti comunque valido, ma efficace ab initio soltanto tra le parti della cessione e giammai nei confronti degli altri soci.
La conclusione pertanto è la medesima cui si è già pervenuti relativamente al caso del trasferimento di quota effettuata dall’unico socio o dall’intera compagine della s.r.l.s. ad uno o più enti: l’atto di cessione, senza la previa o contestuale modifica/adeguamento della società, resterà valido come trasferimento di quota di s.r.l. c.d. a capitale esiguo ma non sarà efficace nell’immediato verso i terzi (compresi gli altri soci e la società).
In altri termini l’efficacia della cessione nei confronti dei terzi in genere (con la precisazione di cui infra per l’intervento nella delibera di recepimento della modifica), sarà subordinata al recepimento della modifica/adeguamento ed alla relativa pubblicità di quest’ultima nel Registro delle imprese, oltre che naturalmente alla pubblicità nel medesimo Registro della cessione stessa.
D’altra parte, se così non fosse, si potrebbe avere la paradossale conseguenza che i soci non cedenti, ignari per ipotesi del trasferimento ad un ente e della conseguente “conversione” ex lege della società, continuino a trattare quest’ultima incolpevolmente come s.r.l.s.
Senza contare che l’esigenza di recepire formalmente con apposita delibera la modifica ex lege della società, frutto del trasferimento all’ente, potrebbe per ipotesi restare sconosciuta all’organo amministrativo, deputato a convocare proprio l’assemblea che dovrà deliberare la “modifica/adeguamento”.
Veniamo ora ad un altro aspetto connesso a quello in parola e di estrema rilevanza per il notaio. Si è concluso poc’anzi nei sensi dell’immediata efficacia inter partes del trasferimento di quota di partecipazione di s.r.l.s. ad un ente, finché non vi sia una formale modifica in s.r.l. c.d. a capitale esiguo o non. Si pone dunque il problema del soggetto che dovrà intervenire alla successiva delibera di recepimento della modifica ex lege in s.r.l. c.d. a capitale esiguo: sarà la persona fisica cedente o l’ente cessionario, debitamente rappresentato?
La risposta non può essere univoca: dipende se il trasferimento della quota di partecipazione sia stato già iscritto al Registro delle imprese e non cancellato d’ufficio; se sia stato solo depositato al Registro delle imprese e protocollato (l’art. 2470, primo co., c.c., stabilisce che il trasferimento della partecipazione ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito all’ufficio del Registro delle imprese competente), ma non ancora iscritto; se infine detto trasferimento non sia stato neppure depositato nel citato Registro.
Nel primo caso, legittimato ad intervenire alla delibera assembleare di “modifica” è l’ente cessionario in persona del legale rappresentante.
Nel terzo caso invece - a meno di non voler aderire ad una opinione che, enfatizzando la facoltà di “re-introduzione” del libro soci ai fini della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, ritiene efficace, anche verso la società, il trasferimento a favore del cessionario, ancorchè non ancora depositato ed iscritto al Registro delle imprese, purché vi sia un consenso di tutti e ciascun socio nonché della società - sarebbe legittimato ad intervenire all’assemblea la persona fisica cedente.
E’ evidente che la fattispecie in grado di suscitare maggiori dubbi operativi sia la seconda: quella del mero deposito con protocollazione al Registro delle Imprese dell’atto di trasferimento della quota, senza che sia ancora avvenuta la relativa iscrizione.
Qualora si segua la soluzione che fa leva sul dato letterale dell’art. 2470, comma 1, c.c., il soggetto legittimato all’intervento ed al voto in assemblea sarà l’ente e poiché il Registro delle Imprese non pubblicizza l’avvenuto deposito bensì solo la successiva iscrizione, nelle more di quest’ultima, sarà onere dell’ente documentare alla società l’avvenuto deposito del trasferimento. Inoltre, nell’ipotesi in cui la richiesta di iscrizione della cessione venisse poi rifiutata dal Gerente del Registro delle Imprese, alla delibera di adeguamento/modifica adottata con l’intervento e il voto del cessionario sarà applicabile l’art. 2479 ter c.c.
La soluzione che fa leva sul tenore letterale dell’art. 2470, comma 1, c.c., già in passato avallata tra l’altro dalla Massima n. I.I.36 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, è stata però recentemente contrastata dalla Giurisprudenza di legittimità, la quale ha interpretato il lemma “deposito” in senso sostanziale, richiedendo che l’atto di trasferimento fosse anche iscritto nel Registro delle Imprese (per quest’ultima tesi si veda, ad esempio, Cass., 27 novembre 2019, n. 31051, in CNN notizie, 17 dicembre 2019, con nota di Boggiali, Efficacia degli atti di disposizione delle quote di s.r.l.).
Stante quanto evidenziato, motivi di prudenza e la funzione anti-processualistica notarile, di Carneluttiana memoria, suggeriscono nella fattispecie di seguire l’opzione interpretativa che attribuisce i diritti sociali in favore dell’ente dopo l’iscrizione dell’atto di trasferimento della quota.
Qualora poi i soci della s.r.l.s. non intendessero per così dire evolvere in s.r.l. c.d. a capitale esiguo, naturalmente dovranno (contestualmente al trasferimento della quota) provvedere ad un aumento del capitale sociale fino ad un importo non inferiore a 10.000,00 euro, non essendo più possibile “sanare” la situazione, effettuando una (retro)cessione delle partecipazioni sociale intestate alla persona giuridica in favore di una persona fisica, visto che ormai il regime di s.r.l. c.d. a capitale esiguo si è ormai instaurato ex lege e di fatto irreversibilmente con l’acquisto della partecipazione di s.r.l.s. da parte dell’ente.
L’accesso di un ente ad una s.r.l.s. (durante societate) è stato in passato ammesso solo per effetto di atti “non volontari”: si è fatto l’esempio dell’acquisto di tali partecipazioni societarie a seguito della successione mortis causa, sia a titolo universale che particolare, del socio (cfr. Massima R.A. 2 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, secondo cui il trasferimento delle quote sociali di una s.r.l.s. è ammesso mortis causa in favore degli eredi o dei legatari, anche se questi sono soggetti diversi dalle persone fisiche; nella stessa linea v. anche Massima n. 128 del Consiglio Notarile di Milano del 5 marzo 2013). Difatti almeno nel caso di apertura della successione legittima e di assenza di successibili entro il sesto grado, la regola del subentro (artt. 565 e 586 c.c.), quale erede, dello Stato ne rappresenta un’espressa conferma (anche in questo caso la società dovrà poi “adeguarsi” nella veste formale attraverso una modifica, essendo divenuta ex lege una s.r.l. c.d. a capitale esiguo).
Una chiosa meritano due ipotesi astrattamente realizzabili proprio nella fase genetica della s.r.l.s.
La prima è quella della previsione, già in sede di atto costitutivo, di diritti reali “minori” in favore di soggetti non persone fisiche. Basti pensare, ad esempio, al caso dell’usufruttuario persona giuridica e del nudo proprietario persona fisica: la circostanza per cui in sede di atto costitutivo i soci possano essere persone fisiche (ex art. 2463 bis, comma 1, e comma 2, n. 1 c.c.) non esclude la legittimità della citata eventualità, in quanto l’usufruttuario della quota non riveste la qualità di socio che rimane in capo al nudo proprietario (cfr. Angelici, Usufrutto di quota di s.r.l. in sede di costituzione della società, in Studi e materiali, Milano, 1995, pp. 149 ss., BOGGIALI - RUOTOLO, Le nuove s.r.l., Studio del CNN n. 892 del 12 dicembre 2013). Pertanto, in questo caso si avrebbe di fatto “la partecipazione” di un ente in s.r.l.s. valida ed efficace fin dall’inizio. Lo stesso vale per il pegno di quota di s.r.l.s., non assumendo il creditore pignoratizio la qualità di socio.
La seconda ipotesi invece concerne l’eventuale partecipazione di una società fiduciaria (e quindi non di una persona fisica) all’atto costitutivo di una s.r.l.s., magari esplicitandosi che la fiduciaria agisce per conto di una persona fisica, di cui però non riveli il nominativo. La soluzione positiva potrebbe essere qui ricercata nella ricostruzione giuridica dell’intestazione fiduciaria (fiducia romanistica o fiducia germanistica) oppure potrebbe forse risolversi attraverso il richiamo al noto brocardo ubi lex voluit dixit, dandosi cioè rilevanza ai soli casi in cui il rapporto fiduciario e sottostante sia stato espressamente contemplato dal Legislatore (ad es. artt. 2504 ter, 2357, 2358 e 2359 c.c.).